
CHIESA
DI SAN
GIOVANNI A
CARBONARA
La
chiesa di San Giovanni a Carbonara sorge in posizione elevata sulla omonima
strada, in prossimità del punto in cui questa si restringe per onorare con una
diversa indicazione toponomastica la memoria di Domenico Cirillo, martire della
Rivoluzione Partenopea del 1799.
L’area,
posta al di fuori delle mura cittadine dalla fondazione di Neapolis fino a tutto
il periodo della dominazione angioina, fu adibita a discarica dei rifiuti cittadini, acquisendo
appunto la denominazione di “carbonarium” (così erano chiamate le aree
destinate a tali scopi anche in altre città), che ha mantenuto fino ad oggi.
In
periodo alto-medioevale l’area fu sede di competizioni (giostre, tornei, corse
di cavalli) molto seguite dalla popolazione e dalla nobiltà, al punto che i
sovrani Angioini vi fecero costruire un imponente edificio, per meglio
assistervi. Il palazzo è ancora oggi visibile, sul lato opposto della strada
rispetto alla chiesa, seppure molto rimaneggiato a causa degli interventi che ne
hanno sostanzialmente modificato l’aspetto nel corso dei secoli a partire dal
Quattrocento ad oggi.
Tali
giostre degeneravano spesso in violente e sanguinose zuffe, con frequenti
omicidi, per cui si ritiene che uno dei motivi che portarono alla fondazione
della chiesa in quel posto sia stato l’auspicio che la presenza di un edificio
religioso nell’area potesse porre
un freno alla violenza dilagante nella zona.
La
chiesa fu realizzata in origine in forme gotiche con una struttura
architettonica relativamente semplice, costituita da un ambiente di sezione
rettangolare, con abside piatta per potervi opportunamente collocare la tomba
del re angioino LADISLAO DI DURAZZO, che con le sue donazioni ne aveva
consentito il completamento. Successivamente,
il prestigio derivante al sito dalla presenza di tale sepoltura fece sì che
alcune famiglie nobili riuscissero a far aggiungere all’originario corpo di
fabbrica le proprie cappelle gentilizie, sistemate dovunque lo spazio
disponibile lo consentiva (dietro l’abside, ai lati del presbiterio, lungo la
navata sinistra e persino all’ingresso, eliminando definitivamente la facciata
della chiesa, che difatti a tutt’oggi ne è priva), modificandone così
sostanzialmente l’originaria struttura.

Foto
1: Veduta del prospetto settecentesco di ingresso al monumento. Si notano
l’ingresso della Conciliazione a Carbonara (in basso) ed il
portale gotico della cappella di Santa Monica (in alto).
Altri
notevoli interventi di trasformazione del complesso furono quelli attuati agli
inizi del Settecento, per porre riparo ai danni causati dal terremoto del 1688,
ad opera dell’architetto FERDINANDO
SANFELICE, che in quella occasione ridisegnò il prospetto d’accesso
al monumento, realizzando la scalinata mistilinea e creando strutture
architettoniche di raccordo tra questa, la cappella di Santa Monica ed il
sagrato in cui è collocato l’attuale ingresso.
Successivamente,
alla metà circa dell’Ottocento, l’interno fu interamente ridecorato
dall’architetto Travaglini, con intonaci e stucchi di stile pseudo-gotico,
perseguendo un intento decorativo di dubbio gusto (in analogia a quanto lo
stesso architetto andava attuando in altre chiese di Napoli, tra cui San
Domenico Maggiore, dove tali “decorazioni” sono ancora oggi ben visibili). A
seguito degli ultimi recenti interventi di restauro, eseguiti per riparare i danni causati alla struttura dai
bombardamenti subiti nel corso della seconda Guerra Mondiale, questa decorazione
è stata totalmente rimossa, contribuendo al ripristino dell’originaria
struttura gotica.
Il
complesso, nonostante i gravi danni subiti a causa dei vari eventi (terremoti e
bombardamenti) che nel corso dei secoli l’hanno devastato, conserva ancora
magnifici monumenti ed insigni opere d’arte.
Tra
questi, il più noto è senza dubbio il grandioso mausoleo del già ricordato re
LADISLAO
DI DURAZZO, ultimo esponente
regale di sesso maschile della dinastia angioina, deceduto nel 1414 ancora in
giovane età (37 anni), nel fiore della vita, al culmine della fortuna e del
successo, proprio nel corso di una ambiziosa azione politico-militare
finalizzata all’unificazione dell’Italia sotto la sua corona (Re
Ladislao già vantava i seguenti titoli: Re di Sicilia, di Gerusalemme,
d’Ungheria, di Roma, di Dalmazia, Croazia, Serbia, Galizia,
Lodomeria, Cumania, Bulgaria, Conte di Provenza, Forcalquier e Piemonte).
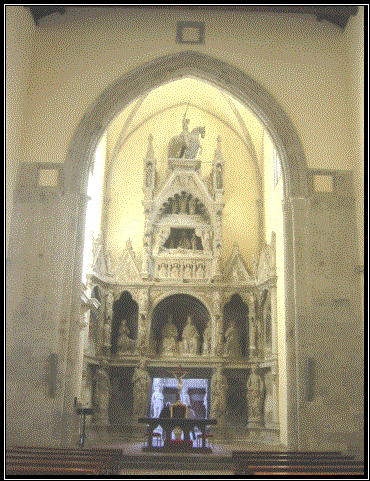
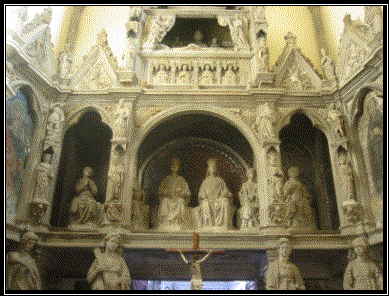
Foto
2-3: Il monumento al re Ladislao di Durazzo (veduta complessiva e particolare
della parte centrale)
Il
monumento fu fatto costruire dalla sorella di re Ladislao, che gli succedette al
trono col nome di GIOVANNA II, ultimo sovrano della dinastia angioina, e
protagonista delle tristi vicende che portarono all’avvento della dinastia
aragonese.
L’opera
fu eseguita con il contributo di vari artisti, sotto la direzione di ANDREA DA
FIRENZE, scultore molto noto nella sua città natale ed in Pisa, e costituisce
un’ulteriore variante dello schema di tomba di stile gotico, teorizzato dal
grande scultore senese TINO DI CAMAINO, caratterizzato in questo caso dalla
grandiosità delle dimensioni: il monumento occupa infatti l’intero spazio
disponibile sulla parete di fondo, sia in altezza (ben 14 m) che in larghezza
(dimensione che addirittura travalica, invadendo le due pareti adiacenti con
portelle marmoree che racchiudono due dipinti raffiguranti San Giovanni Battista
e Sant’Agostino, opere di LEONARDO
DA BESOZZO, pittore lombardo
attivo anche in altre parti della chiesa).
Tra
le varie sculture costituenti il monumento sono degne di nota:
·
le cariatidi di base,
raffiguranti Virtù , per le analogie riscontrabili tra una di esse (la
Prudenza, la seconda da destra) e l’analoga opera eseguita dal MICHELOZZO,
congiuntamente con DONATELLO,
in Sant’Angelo a Nilo (tomba del cardinale Brancaccio)
·
le figure di Ladislao e
Giovanna II in trono, per la qualità scadente, specialmente in relazione
all’espressività dei volti, in contrasto con la posizione centrale occupata
nel monumento
·
la figura del vescovo,
benedicente il corpo del re disteso sul sarcofago, opportunamente inserita nel
contesto in quanto re Ladislao morì scomunicato
·
l’imponente figura del
re a cavallo che sovrasta il monumento funebre, di ispirazione non certamente
centro-meridionale
·
infine, le statuette di
santi inserite in nicchiette sui pilastri del monumento, che costituiscono dal
punto di vista artistico la parte migliore del monumento, opere eseguite
direttamente da ANDREA DA FIRENZE, a
cui va anche attribuita la regia dell’intera opera.
Alle
spalle del monumento, con ingresso tra le due cariatidi centrali, è posta la
grande, luminosa cappella di patronato della famiglia Caracciolo del Sole,
mentre alla sua sinistra uno splendido arco rinascimentale introduce nella
cappella di patronato dei Caracciolo di Vico. Queste due cappelle, costruite in
epoca successiva alla chiesa e, come le altre, non pertinenti al
progetto originario, racchiudono
in sé testimonianze storico-artistiche di notevole rilevanza, tali da meritare
una descrizione sicuramente più
ampia rispetto a quanto consentito nel presente contesto, necessariamente
sintetico per motivi di spazio. A
tali cappelle sarà pertanto successivamente dedicata un’intera tappa
di questo nostro percorso storico-artistico.
Altra
opera di notevole interesse presente all’interno della chiesa è il grande
monumento MIROBALLO, fatto
costruire dalla omonima famiglia e dedicato a San Giovanni Evangelista. Il
monumento, posto lungo la parete sinistra della navata proprio di fronte
all’ingresso attuale, fu realizzato nella seconda metà del ‘500 da artisti
lombardi (JACOPO
DALLA PILA, TOMMASO MALVITO e suo figlio GIOVANTOMMASO).
E’ costituito da un grande arco a tutto sesto che incornicia l’altare, sul quale troneggia la magnifica scultura di San Giovanni Evangelista, opera di GIOVANNI MERLIANO DA NOLA , il più importante scultore rinascimentale dell’Italia Meridionale; le altre parti del monumento sono arricchite da numerose statue di santi e virtù, tutte opere dei sopracitati artisti lombardi.

Foto
4: L’altare Miroballo
Come
già accennato in precedenza, la chiesa è stata privata della facciata e
dell’ingresso principale per lasciare spazio alla costruzione di una delle
tante cappelle gentilizie che, nel corso del tempo, si sono aggiunte alla
struttura originaria. La famiglia Di Somma, infatti, a cui apparteneva uno
Scipione che fu consigliere dell’imperatore Carlo V, pretese di utilizzare lo
spazio antistante l’ingresso principale per costruire la propria cappella
gentilizia, cancellando di fatto ogni traccia della originaria facciata della
chiesa. La cappella è caratterizzata da un classico equilibrio architettonico,
scandito da dodici colonne corinzie distribuite lungo le pareti, inquadranti
spazi tra i quali troneggia, in posizione centrale ed in linea con l’asse
maggiore della chiesa, il monumento funebre del già citato Scipione Di Somma.
L’opera fu eseguita in collaborazione tra ANNIBALE
CACCAVELLO
e GIOVAN DOMENICO D'AURIA,
due validi esponenti della scultura rinascimentale nel Meridione (il primo fu allievo di Giovanni da Nola); ai due artisti è attribuito
anche il progetto architettonico dell’intera cappella, nonché l’esecuzione
di tutte le altre opere di scultura presenti in essa. Ne completano la
decorazione gli affreschi, inseriti tra cornici e stucchi della volta, e i
dipinti ad olio su muro delle pareti laterali. L’insieme, tuttavia, non
risulta particolarmente gradevole allo sguardo, pur essendo artisticamente
valido (come invece avviene per le splendide cappelle dei Caracciolo del Sole e
dei Caracciolo di Vico), a causa dei pesanti strati di polvere e di sporco che
col tempo vi si sono depositati, creandovi un’atmosfera tristemente opaca.

Foto 5: Particolare dell’Annunciazione, di GIOVANNI DA GAETA
Tracce
di decorazione ad affresco della chiesa, risalenti alla prima metà del
Quattrocento, sono visibili alla sinistra del monumento Miroballo (Storie di San
Nicola da Tolentino) e sulla parete a destra dell’ingresso (Annunciazione, di GIOVANNI DA GAETA). Un altro
affresco coevo, recentemente restaurato, si trova sul portale gotico di ingresso
alla chiesa, dal lato esterno; raffigura Sant’Agostino e San Tommaso, ed è
anch’esso opera di
quel
LEONARDO DA BESOZZO
che abbiamo già incontrato accostandoci al mausoleo di re Ladislao, e che
ritroveremo autore di un bel ciclo di affreschi nella cappella dei Caracciolo
del Sole.
Altre
sculture degne di nota, presenti all’interno della chiesa, sono le due Madonne
col Bambino, opere di MICHELANGELO NACCHERINO, scultore toscano allievo del
Giambologna (e, secondo alcuni, allievo dello stesso Michelangelo Buonarroti), e
l’altare della Purificazione col sarcofago di Biagio Marsicano, opera del già
citato ANNIBALE CACCAVELLO.
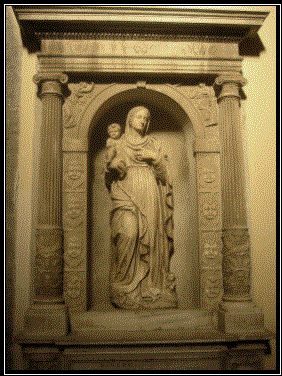

Foto
6-7: Le due Madonne col Bambino, di MICHELANGELO NACCHERINO
Infine,
uscendo sul sagrato e ridiscendendo verso la strada, si accede alla chiesa
inferiore, la Consolazione a Carbonara, sede parrocchiale, interessante perché
custodisce due altari appartenuti in passato alla chiesa superiore: il barocco
altare maggiore, che fu altare maggiore di anche San Giovanni, opera di
GIUSEPPE
SANMARTINO (autore del celebre Cristo Velato nella Cappella Sansevero), ed un
altare cinquecentesco adorno di pregevoli bassorilievi.
Qui
si conclude la sommaria descrizione delle splendide opere d’arte visitabili
nel complesso di San Giovanni a Carbonara, complesso che, per il numero, la
varietà, e l’indubbio, squisito valore storico-artistico delle opere che
contiene, meriterebbe
un
ben più cospicuo numero di visitatori, rispetto alle poche unità che
quotidianamente vi accedono (è emblematica, a tal
proposito,
la decisione del Comune di Napoli di prevedere per il presidio di tale monumento
una sola unità, a differenza delle due normalmente previste per altri monumenti
del Centro Storico).
Ma
il complesso ospita anche altre opere d’arte, anch’esse di notevole pregio
artistico, purtroppo oggi non visitabili, che elenchiamo sommariamente qui di
seguito:
·
la gotica cappella di
Santa Monica, nella quale si trova il sepolcro di Ruggiero Sanseverino, altra
notevole opera di ANDREA DA FIRENZE (l’artefice del mausoleo di re Ladislao)
·
la cappella Seripando,
che oltre ad ospitare il cinquecentesco mausoleo di Antonio Seripando, vanta la
presenza sull’altare di un prezioso Crocifisso su tavola, opera del pittore
toscano GIORGIO VASARI
·
i chiostri,
stilisticamente diversi tra loro ma tutti, sembra, di pregevole fattura, al
momento non visitabili perché sottoposti a restauro
Aldo
Lubrano